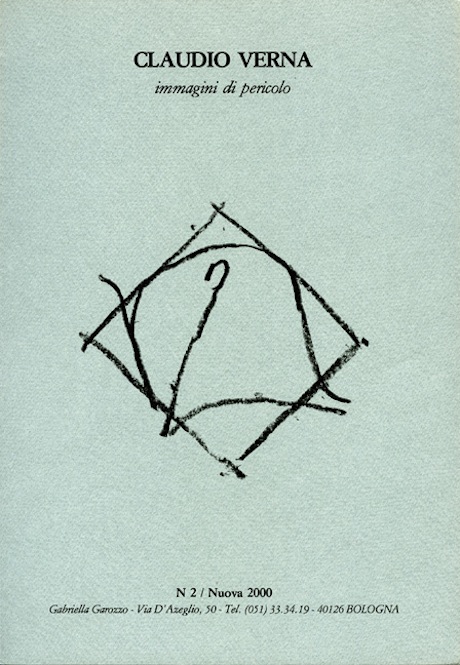 Claudio Verna, immagini di pericolo, catalogo personale Galleria N 2 / Nuova 2000, Bologna, 1986
Claudio Verna, immagini di pericolo, catalogo personale Galleria N 2 / Nuova 2000, Bologna, 1986
Sono passate finalmente molte acque, sotto il ponte delle petizioni di principio e delle giaculatorie onnicaptanti. E la pittura di Claudio Verna è ancora qui, alle soglie di un’akmé fatta di saporosi azzardi qualitativi, di toni espressivi tutti maggiori, anziché del corrispondere meccanico alle ragioni contingenti di un clima.
Cresciuto nell’asse continuo di mediazione tra le necessità dello psichico, di una soggettività eretta a unicum mitico, di una pittura fondamentale vocata a ricostituirsi in corpo dotato di senso, d’un canto, e dall’altro la consapevolezza che ciò presuppone scelte, e processi, e «l’espressione semplice del pensiero complesso» (Neuman), ampio e potente ma senza eloquenza, e l’atteggiarsi entro una superficie perimetrabile perché sia mentalmente esperibile, Verna ha filtrato tali termini problematici fino a renderli non poli di una tensione drammatica, ma assetti naturali, congruenti della propria pittura.
Ha scelto, nuovamente, di correre il rischio dell’orizzonte – penso alle cesure rothkiane di Foxtrot, 1978, all’esplicito Pittura, 1979 – assunto però a perno di una qualità spaziale totalmente altra, introversa, costituita per crescita organica del colore e dei suoi segni.
Ha consentito che le grandi stesure si producessero per stratificazioni laboriose, increspate di toni, per movenze modulate, senza assertività, così da entrare in profonda risonanza con il passo aperto, ampio ma concentrato, dei gesti lunghi portatori d’un vibrante tessuto emotivo.
Senza concedersi al prestigio esteriore della grande maniera, della forzatura di grazia: con una sorta, anzi, di sottile pudore, di reticenza che tende a risolvere l’opera per via di trasparenza e ambiguità, e farla figlia d’una intensità felice così autentica da non dar luogo ad abbigliamenti sensibilistici.
Questo spazio si da così come luogo proprio, non proiettivo, territorio d’una geografia d’affetti che ha scelto di dipanarsi con fluenze lente, come continuamente sospese, esitanti a dirsi, nitidamente renitenti all’orgasmo, eppure piene, mature, senza rigoristiche economie di senso.
Uno spazio capace di produrre anche climi, e atmosfere, suoi propri, temperature e densità specifiche, com’è nella serie straordinaria, 1982-1984, dei Clamori (dell’autunno, dell’inverno, della primavera, dell’estate), in cui l’innesco letterario, che parla di certa poesia ermetica e d’impressionismo, vale da reagente laicamente problematico, né privo d’autoironia, alla ritrovata capacità della pittura d’essere fenomeno totale, la cui stessa distanza di memoria è fatta di valori definitivamente pittorici.
Ecco, forse la ragione fondante l’attuale stagione di Verna è proprio questa: il saper essere dentro la storia dalla parte del senso anziché da quella delle prosecuzioni senza necessità: dalla parte delle ragioni semplici dell’espressione anziché di quelle mortuarie dell’ideologia del museo; dalla parte della felicità d’essere anziché del frigido dover essere.

