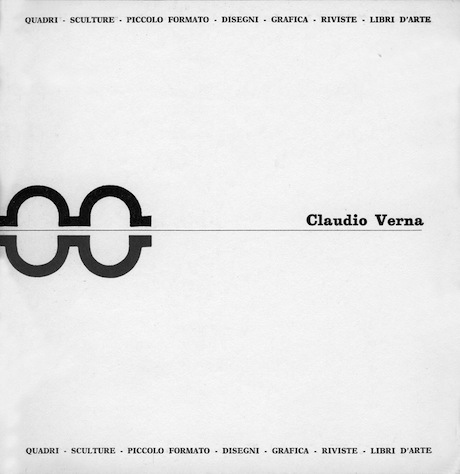 Claudio Verna, catalogo personale Galleria Arco d’Alibert, Roma, febbraio 1968
Claudio Verna, catalogo personale Galleria Arco d’Alibert, Roma, febbraio 1968
Ci siamo ormai tutti abituati a passare da una galleria all’altra, da uno studio di pittore o di scultore all’altro, con lo stesso spirito con cui da ragazzetti già grandicelli (e quindi insofferenti e smaniosi di giochi all’aria aperta) eravamo costretti il giovedì santo a visitare i «sepolcri» peregrinando da questa a quella chiesa. Per fortuna accade talvolta, anche se non troppo spesso, di imbattersi in una vera opera e in un vero artista; evento che, per quanto riguarda me come ogni altro critico «militante», legittima e riscatta il faticoso trascinarsi fra i troppi altarini, addobbi più o meno riusciti, paramenti da fratelloni della buona morte che comunemente si rinvengono oggi in gallerie e studi. Ogni tanto, insomma, si incontra un pittore come Verna, l’opera del quale mi sembra impressionante per la chiarezza e la lucidità della visione, per la serietà della ricerca, per la validità poetica dei risultati.
Verna è nato artisticamente a Firenze, ma da parecchi anni vive a Roma dove sin qui ha lavorato in un isolamento pressoché totale. Per educazione e per elezione egli è, comunque, in questo momento di raggiunta maturità, pittore tipicamente romano, da inserirsi (se proprio si desidera trovargli una genealogia e appiccicargli una qualche etichetta) in quel settore di ricerche spazio-luministiche che trae origine da Balla.
Nonostante talune apparenze, infatti, le sue tele, riempite da grandi strutture colorate che invadono lo spazio in geometrie tanto rigorose quanto irregolari, non si pongono se non problemi puramente pittorici, problemi di ritmo e di colore-luce. Sarebbe del tutto sbagliato, voglio dire, leggere questi quadri in termini di «strutture primarie» o di semplice occupazione e scansione di una superficie; il fondo bianco, accecante, su cui le strutture di Verna aggallano, non è da esse spezzato o interrotto ma in esse si rifrange, poiché tra queste varie e diverse luminosità vi è una differenza quantitativa ma non qualitativa. Tanto è vero che in alcune opere le strutture (e sia chiaro che le definisco così solo per comodità) sono individuabili unicamente in virtù della loro «carica» interna, espressa nel vago barbaglio cromatico che le fa nascere, bianche, dal bianco.
In un certo senso potrei dire che il lavoro di Venia consiste nel proporre una struttura e contemporaneamente nel negarla; ciò è solo apparentemente paradossale, poiché in altri termini significa che la costruzione geometrica del quadro almeno oggi è pretestuosa, «serve» il colore anziché esserne servita.
Almeno oggi, ripeto, perché questo annullamento della geometria nella luce è una conquista attuale di Verna, per l’addietro attentissimo e calibratissimo ricercatore di armonie «matematiche», ottenute anche con l’impiego di forme fisse se non di veri e propri «moduli».
(Vero è che, anche allora, i problemi i quali maggiormente lo interessavano erano sempre inerenti al colore-luce e che il senso profondo della sua ricerca non è mai cambiato). Basta però vedere con quanta finezza e con quanta precisione di calcolo il risultato è raggiunto, grazie a una serie di spinte e controspinte cromatiche amministrate con strenuo rigore, per rendersi conto dei fatto che se la costruzione è pretestuosa non per questo essa non è necessaria. Verna è un pittore per il quale la geometria è stata ed è uno strumento di lavoro, anche se non è un pittore «geometrico».
I mezzi che Verna ha scelto per esprimersi sono i più adatti alla sua natura, proba e castigata ma tutt’altro che fredda. Alcuni dei quadri qui esposti, che non esito a dichiarare francamente splendidi, rivelano al contrario quanto fuoco bruci tra le orditure di meccanismi formali così elaborati e impeccabili, quanta libertà sia sottesa a un ordine mentale così assoluto.

