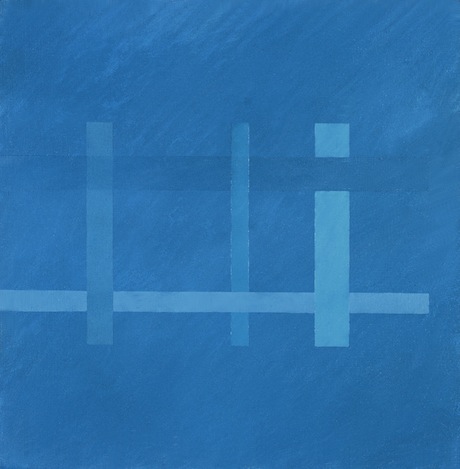 LE CONTRADDIZIONI DI FONDO
LE CONTRADDIZIONI DI FONDO
Circa dieci anni fa, prevalse la tendenza a considerare la pittura come antiquariato. Ripetendo ancora una volta l’operazione che ha perpetuato fino ad oggi molti equivoci sulle avanguardie, alcune correnti artistiche furono avvalorate dalla critica e sostenute dal mercato non in quanto affrontavano o sviluppavano in modo nuovo le premesse e le contraddizioni di fondo dell’arte moderna, ma in quanto si ponevano, pregiudizialmente, come diverse da tutto ciò che le precedeva.
Negli ultimi 50 anni, il ritmo di simili scarti si è fatto sempre più frenetico: una corrente scavalca l’altra, come un modello di auto invecchia il precedente. Le avanguardie si succedono in modo nevrotico, secondo la logica tipica di una critica miopemente storicistica, obbedendo di fatto alle imposizioni del mercato, che obiettivamente fissa le leggi e istituzionalizza l’attuale legame dell’arte con la società. Quando, verso il ’72, si rinnova un certo interesse per la pittura, l’equivoco è lo stesso. Le esigenze del mercato sostengono la pittura con i vecchi sistemi e vizi, in altre parole ancora come neo-avanguardia, mentre prende corpo il sospetto di una ennesima involuzione. La pesantezza del gioco, salvo opportune eccezioni, è mostrata dal disinteresse per i motivi che avevano spinto dei pittori ad insistere con tanta ostinazione nella propria ricerca, come pure dalle scelte e dalle rassegne proposte.
Si impongono almeno due considerazioni e sono le stesse che già si ponevano all’inizio degli anni sessanta: innanzitutto, l’urgenza di approfondire lo studio delle contraddizioni dell’arte moderna, per sfuggire in qualche modo alla circolarità delle esperienze di gran parte dell’arte contemporanea; e poi, la necessità di esaminare senza ipocrisie le implicazioni del mercato e gli eventuali modi per impedirne il condizionamento.
Quanto al mercato, metterlo in discussione significa analizzare il rapporto con la società in tutte le sue espressioni, dalla galleria al museo, dal collezionismo alla carriera, ai rapporti con la critica e così via. Non si tratta di sostituirsi al sociologo, ma casomai di riconoscere agli artisti il diritto di intervenire nella gestione della politica dell’arte. D’altro canto, esaminare le contraddizioni dell’arte moderna significa necessariamente rifare la sua storia: un compito che è proprio di ogni generazione (e che non ho la pretesa di risolvere con queste note). Non si dà arte senza la critica di questi due dati, né la pittura esisterebbe al di fuori di un riesame continuo di se stessa come pratica specifica e come prodotto insieme di un soggetto e della storia. Ma questo esame non può avvenire solo in teoria: un artista lo compie nella consapevolezza del suo lavoro, esercitando la speculazione nel momento della prassi. Scissa dalla speculazione, la prassi diventerebbe empirica e quindi criticamente passiva rispetto ai modelli della tradizione (nel migliore dei casi, potrebbe ridursi a strumentazione didascalica di una teoria, con relativo scadimento e perdita di significato); per lo stesso ordine di motivi, la speculazione, senza il coinvolgimento del lavoro, finirebbe inevitabilmente col porsi sul piano idealistico, fuori dalle concrete possibilità dell’arte (da cui la «morte dell’arte»).
Essere consapevoli delle ragioni che sono alla base del proprio lavoro significa anche lucidità nell’accettare i compromessi inevitabili e mantenere questa lucidità all’interno del sistema in cui si opera. Perché un problema è anche questo: se si debba utopisticamente operare in ipotetiche aree culturali incontaminate, quindi deboli e senza agganci con la realtà, oppure elaborare la propria esperienza e condurre la propria azione all’interno delle strutture esistenti. Personalmente sono convinto che scegliere l’esilio significhi porsi in una specie di orbita di parcheggio, con il pericolo reale di essere brutalmente strumentalizzati quando l’eventuale carica innovativa sia giudicata ormai inoffensiva o facilmente recuperabile.
LA FUNZIONALITA’
Una delle critiche più insidiose che vengono fatte ai pittori riguarda una loro supposta mancanza di funzionalità rispetto al contesto sociale: consapevoli del fatto di non avere reali interlocutori e destinatari, i pittori nasconderebbero la propria cattiva coscienza di meri produttori di oggetti estetici, esibendo una loro privatezza gelosa, oppure sovrabbondando in teoria: due forme di giustificazione, insomma, riferibili la prima all’area italiana e tedesca, e la seconda a quella francese(1). L’accusa non è del tutto infondata ed è difficile rovesciare il giudizio anche tenendo conto delle tradizioni dei vari paesi. (Negli Stati Uniti, un pragmatismo tradizionale spinge gli artisti ad identificarsi unicamente nell’azione, anche se le generazioni più recenti hanno avvertito la necessità di coniugare la prassi con una più serrata speculazione sulle ragioni del proprio lavoro).
Ma l’impasse storico e sociale in cui i pittori sono costretti ha origine già nel secolo scorso con la frattura determinatasi tra istituzioni e ricerca, tra rappresentazione e conoscenza. Se la consapevolezza di questa situazione non impedisce loro di operare entro confini che qualcuno, moralisticamente, ritiene vincolanti, ciò dipende dal fatto che gli artisti non hanno destinatari specifici (anche se storicamente è stata spesso una sola classe a chiedere i loro servizi, che poi tutti hanno pagato senza goderne subito e direttamente).
Il lavoro di un pittore è un processo di conoscenza che riguarda l’autore come ogni possibile destinatario, e per far questo l’artista ha l’obbligo di usare i mezzi più congeniali a se stesso e all’operazione. Il problema quindi non si pone tra un’azione dall’interno o dall’esterno (?) del sistema sociale in cui si vive, ma riguarda invece la consapevolezza dell’azione, anche in rapporto ai possibili mutamenti di quel sistema.
Inoltre, l’artista, se ha il dovere di difendere fin che può il suo lavoro dall’uso e abuso che tenta di farne il potere, non può rinunciare a priori a condurre la propria ricerca per il fatto che i possibili risultati correranno il rischio (purtroppo molto probabile) di essere strumentalizzati e fraintesi a breve termine.
L’unica alternativa concreta ad una situazione eventualmente non più sostenibile è l’abbandono della pratica artistica per la politica vera e propria: il che implica una serie di risposte sui problemi della opportunità e utilità di una simile scelta. Comunque, storicamente, ci sono stati periodi e momenti in cui anche gli artisti hanno lasciato la loro azione specifica per compromettersi senza mediazioni con la realtà: e non è detto che simili circostanze non debbano ripetersi.
Fuori da queste ipotesi, c’è solo la demagogia e il gioco (apparentemente in buona fede ma di fatto protervo perché rivolto al potere) delle avanguardie. Insomma gli artisti sanno di poter sviluppare il loro lavoro solo con la sistematica elaborazione di una teoria e di una pratica dell’arte che recuperi la sua necessità senza bisogno di giustificazioni.
Certo che nel momento in cui il potere privilegia la scienza identificandola con i propri mezzi di produzione, l’artista viene a trovarsi ufficialmente ai margini della socialità; ma è altrettanto vero che ciò che più irrita il potere non è il gesto isterico e spettacolare, o il feticismo decadente, ad esempio di tanta arte povera, ma la critica continua e sistematica condotta con gli strumenti più perfezionati e teoricamente agguerriti.
Non bisogna dimenticare che è sempre il potere, in ultima analisi, ad avere bisogno dell’arte, e mai viceversa. Ecco quindi che rifarsi ad una disciplina come può essere la pittura, ma contemporaneamente esaminando ogni possibile contributo e scambio con altre discipline (basti pensare al marxismo, alla psicanalisi e allo strutturalismo), non significa rassegnarsi ad una posizione subordinata o addirittura fiancheggiatrice del sistema, ma al contrario serve a qualificare i propri strumenti per agire col massimo dell’efficacia in un campo, l’arte, forse limitato, ma strategicamente vitale.
DISCIPLINA E SPECIALIZZAZIONE
Pittura come disciplina, dunque, e non come specializzazione. La specializzazione è scientificamente una tecnica volta ad un fine, uno scopo, quale ad esempio può essere la propaganda nel realismo socialista (o l’efficacia nella pubblicità). In questo caso la pittura accetta una motivazione pratica che la precede e si giustifica in essa, ma si annulla come disciplina. Infatti l’arte ha un senso (esiste), ma non può avere un obiettivo fuori di sé, perché allora vanifica il suo procedimento una volta raggiunto il fine prefisso.
Parlare di discipline, comunque, non significa fare il catalogo delle possibilità di fare arte: si tornerebbe ad ipotesi scientifiche o religiose accettate aprioristicamente come verità metafisiche. Una disciplina come la pittura, qualunque disciplina, ha senso in quanto permette di sperimentare le possibilità creatrici che ognuno di noi possiede come impulsi vitali. E siccome l’uomo non è un animale astorico, riceve dalla tradizione un bagaglio di nozioni e di istituti linguistici che lo inseriscono in determinate condizioni, appunto storiche, nell’ambito e nei confronti delle quali eserciterà la sua speculazione e la sua prassi.
Paradossalmente, se si potesse parlare di uno scopo in arte, questo sarebbe la critica di sé, cioè l’analisi e la sperimentazione di nuove discipline. Si potrebbe allora azzardare una definizione possibile, ma pur sempre enormemente riduttiva, di arte, come linguaggio sperimentale per eccellenza.
L’ARTE CONCETTUALE
Proprio come sperimentazione, la pittura, come le altre discipline, è stata posta sotto accusa dall’arte concettuale, per la quale non ha valore, anzi è indifferente il modo in cui si comunica «il procedimento mentale che sta a monte dell’operazione»(2). Più precisamente, «quando un artista usa una forma concettuale d’arte, significa che tutti i progetti e le decisioni vengono sviluppati all’inizio, e l’esecuzione è cosa secondaria. L’idea diviene la macchina che produce arte»(3). Insomma, i concettuali indagano il sistema stesso dell’arte, intendendo questa, tautologicamente, come significato svincolato dal significante, come definizione di se stessa, come atto mentale. Non si analizzano le pratiche del fare consapevole, le discipline che storicamente si sono date e si trasformano, ma le strutture creative, i problemi che riguardano i rapporti convenzionali dei segni e le relazioni tra le unità elementari linguistiche. Naturalmente, in questa concezione, l’arte «è pura, non essendo debitrice che di se stessa»(4). Che in qualche modo si manifesti è pur sempre utile, ma il procedimento non avrà alcun valore: l’importante è che, una volta scelto, sia perfettamente passivo rispetto ai significati che gli stanno a monte, e venga usato con la massima coerenza possibile. Il risultato, quindi, sarà una didascalia dell’idea iniziale che contiene già tutte le varianti possibili, cioè meccanicamente prevedibili. Infatti, nel momento in cui il significante è totalmente asservito al significato, non si annulla soltanto l’aspetto virtuosistico del fare, ma il valore stesso del processo, cioè si nega l’arte come esperienza.
Un passo ulteriore è quello compiuto da Bernar Venet, al quale sembra che, pur rimanendo nella logica concettuale, i mezzi usati possano riferirsi a significati diversi, rischiando in qualche misura l’ambiguità: ecco allora che propone nel campo dell’arte il codice matematico che libera il quadro dagli ultimi pericoli: l’espressività e l’estetica.
E’ chiaro a questo punto che «l’interesse per l’arte e la sua sopravvivenza essendo dovuto proprio al delicato equilibrio tra linguaggio e significato, l’incapacità di avvertire come invenzioni vive in se stesse le tecniche e le forme dell’arte del passato, condurrà inevitabilmente all’idea della fine dell’arte»(5), conclusione già ipotizzata come involuzione idealistica e di fatto grottesca (ma già sperimentata dallo stesso Venet).
Ora, che l’arte concettuale abbia recato un grosso contributo nel ripensamento analitico del concetto stesso di arte, è evidente; ma non si può negare che il suo sbocco finale è consistito, per i più almeno, in un congelamento del concetto di arte, in una involuzione tautologica su se stessa. La realtà è troppo più complessa di qualsiasi schematizzazione perché queste possano soddisfare la nostra ansia di stabilire con la stessa realtà un rapporto non puramente metafisico.
La riflessione sul passato, su quanto già conosciamo serve unicamente in quanto ci proietta in una dimensione che in qual che modo, magari utopisticamente, contenga anche la speranza del futuro. La problematica dell’arte non è risolvibile astraendola nelle sue sole connotazioni critiche o nei suoi equilibri linguistici: si nutre invece di tutti i contributi teorici e pratici, che la ricchezza del reale mette a sua disposizione, in un contesto dove «alla chiarezza si può opporre l’oscurità (non l’incomprensione)»(6), al prestabilito il caso, al presunto certo l’ambiguità del dubbio.
Per cui, se è giusta la critica dei concettuali a termini vaghi come le qualità estetiche o l’abilità manuale, non si vede come si possa negare validità alle diverse discipline che dell’indagine concettuale tanti presupposti possono agevolmente condividere. Ad esempio, il problema della sostanziale ambiguità dell’oggetto estetico in quanto prodotto mercificabile, è esattamente lo stesso che si è posto il pittore moderno quando ha riesaminato il suo quadro (da Cézanne in poi), smitizzandolo a favore di un metodo sistematico di conoscenza.
LA MERCIFICAZIONE
La mercificazione dell’arte, subentrata alla fase del mercato inteso come opportunità di scambio e circolazione di opere in quanto valori, ha di fatto imposto nel mondo artistico le regole del consumismo: vorticosa rotazione delle avanguardie, quantità al posto della qualità, tentativo di asservire gli artisti col ricatto economico(7). Ma alla mercificazione non si sfugge non vendendo (la merce rimane merce anche in magazzino), né inventando un circuito mercantile autogestito: ancora una volta lo scontro è possibile solo all’interno delle strutture esistenti, accettando di vivere fino in fondo la crisi del proprio tempo, usando gli strumenti (teoria e prassi come disciplina) che sono le armi degli artisti.
La necessità che sempre il potere ha della cultura e dell’arte è lo spazio e l’opportunità che gli artisti devono sfruttare per rivendicare la loro autonomia; solo a queste condizioni, potranno avere ancora il diritto di credere nell’efficacia del proprio lavoro.
IL RAPPORTO CON LA CRITICA
La speculazione è dunque un aspetto troppo importante del suo lavoro, perché un artista possa presumere di elaborarla dialetticamente con un apparato critico e linguistico che solitamente non gli appartiene (lo provano queste note). Quando un pittore, cioè, si pone sullo stesso piano del critico e dello storico, non spezza le barriere di classe che dividono gli esecutori dai sapienti(8), ma rischia semplicemente di non essere né l’uno né l’altro. La speculazione di un artista serve a dargli la consapevolezza critica del territorio e degli strumenti con cui agisce, ma è pur sempre soltanto con la sua opera che potrà tentare di decifrare, con tutti i suoi limiti, il proprio rapporto con la realtà.
Questa consapevolezza, inoltre, gli consente non di giustificare il proprio lavoro, ma di ipotizzarlo teoricamente, permettendone una lettura il meno possibile equivoca, e di aprirsi a tutte le possibilità che sono inerenti alla sua ricerca. Che poi il lavoro sia ancora altro, e possibilmente di più, va benissimo. Quindi il lavoro di un artista va analizzato sia sul versante della teoria («un pittore non dipinge solo con le mani») sia nel suo concretizzarsi nell’ambito di una disciplina. I due momenti trovano riscontro nell’analisi del soggetto e della storia, cioè delle due forze che concorrono al manifestarsi dell’arte. Ricondurre a unità i diversi aspetti dell’indagine critica è appunto il compito dello storico dell’arte che, in questo, dovrà elaborare una disciplina a sua volta creativa, ovviamente diversa da quella dell’artista.
Lo storico potrà così portare in luce tutti gli elementi che hanno concorso al processo artistico, compresi quelli che hanno agito a livello inconscio nell’artista. L’opera con ogni probabilità non corrisponderà integralmente al progetto dell’artista; ma anche la lettura del critico, in fondo, sarà relativa. E l’arte continuerà a smentire ogni sua definizione.
L’AUTONOMIA DELL’ARTE
Ogni discorso sulla pittura, dunque, porta necessariamente a considerare l’artista un homo faber in cui evidentemente è il faber che fa l’homo e non viceversa. Questo significa anche che la pittura esiste in quanto elaborazione insieme critica e pratica, come dialettica tra percezione e pensiero. Ma se la pittura è senza dubbio un procedimento specifico, si può dire che è anche autonomo?
La sua identità è data unicamente dagli elementi che la costituiscono o anche da ciò che la differenzia dalle altre discipline e magari dal rapporto con queste differenze?(9).
In altre parole, qual è il legame che unisce la realtà della pittura al resto della realtà?
Senza considerare quella pittura che attraverso i canali della astrazione si illude di comunicare contenuti codificati dalla tradizione che di fatto le sono estranei, come si concilia eventualmente l’autonomia con un rapporto possibile con la realtà storica e sociale?
Non si può dimenticare che spesso, di fronte alle difficoltà della storia, la pittura astratta ha significato una pura e semplice evasione verso le alienanti libertà del razionalismo metafisico. La frattura storica tra arte e vita è risolvibile, oppure bisogna per forza ipotizzare (Marx, Mondrian) un futuro in cui non ci sarà più bisogno dell’arte?
Tutte le avanguardie hanno tentato di rispondere a queste domande e più di tutti i movimenti comportamentistici e body che tuttavia, pur nel loro entusiasmo, non possono rinunciare, di fatto, a proporre un progetto estetico entro cui vivere una (parziale) libertà. E d’altra parte, senza quel progetto, mancherebbe qualunque indizio di un reale processo di riavvicinamento tra arte e vita.
Gli stessi limiti condizionano la pittura, che spesso è avvilita a semplice programmazione stilistica e normativa, a variazioni esclusivamente formali dei modelli delle avanguardie storiche. Il formalismo vecchio e nuovo, d’altra parte, afferma senza esitazioni l’autonomia dell’arte e nella sua analisi ha forse raggiunto i risultati più convincenti: la pittura è vista giustamente nell’articolazione dialettica dei suoi elementi strutturali, in cui il risultato testimonia sia la riflessione sull’arte, sia il processo creativo che l’ha determinato. (In questo concordano, nella sostanza, sia Cézanne sia i maestri dell’action painting americana). Ma è lecito forse chiedersi se, al di là della specificità, l’autonomia dell’arte non sia in qualche misura causa della posizione alienante degli artisti e dell’arte stessa nella condizione odierna.
Un tentativo di uscire dall’impasse è quello teorizzato da alcuni pittori e critici francesi(10) con l’analisi delle determinazioni politiche e psicanalitiche dell’arte: ma anche se i loro studi sono tra i più stringenti e utili, rimane il dubbio che si siano compiute semplificazioni schematiche eccessive, con il rischio di sostituire delle regole dichiarate decadute o regressive con altre leggi che anch’esse restringono il fenomeno e in parte lo avviliscono. La riprova di queste contraddizioni sta nel divario avvertibile tra speculazione e prassi. Con le parole si può anche pretendere di isolare le leggi e le determinazioni della pittura (dell’arte) senza però dimenticare mai che questa rimane pur sempre, pena la sua scomparsa, un procedimento attraverso il quale l’uomo ha la possibilità di capovolgere quelle regole, riaffermando in questo la sua libertà e le sue capacità creatrici.
Il problema dunque rimane e la difficoltà di dargli risposte esaurienti dipende in larga misura dalla riconosciuta impossibilità di definire l’arte. D’altro canto, avere a che fare con questo ostacolo è il senso e la ragione stessa del nostro lavoro. Le certezze, per fortuna, sono molto meno esaltanti.
E’ MORTO IL QUADRO, VIVA LA PITTURA
L’impossibilità di definire l’arte non esclude, anzi stimola la riflessione sulla pittura: è del resto l’unico modo per non considerarla qualcosa di immutabile, ma un procedimento che mette continuamente in discussione il codice che lo precede. Per verificarlo, basterebbe una analisi sia pure sommaria dell’impressionismo, che rifonda il linguaggio della pittura considerando la struttura cromatica del quadro non più in funzione dell’immagine ma delle leggi specifiche del colore, in base alle esperienze scientifiche condotte da Chevreul sul contrasto simultaneo dei colori. Non c’è salto di qualità, non c’è progresso in tutto questo, ma la pittura si trasforma e vive in un contesto profondamente mutato.
E’ comunque quello che avviene subito dopo a porre i presupposti per quanto si va facendo ancora oggi: l’analisi di Seurat sulla organizzazione sintattica degli elementi linguistici di base; l’accanimento di Monet sulla specificità dei procedimenti percettivi; la lucida sperimentazione di Van Gogh sui valori autonomi del colore; tutta l’opera di Cézanne. Comune a questi artisti è la sfiducia nella convenzionalità del racconto, cioè della rappresentazione. Sebbene ancora attenti a non perdere il contatto con la realtà visibile della natura, pongono tutta la loro capacità di indagine sugli elementi costitutivi della pittura, da un lato consapevoli del vicolo cieco cui poteva portare l’impressionismo, dall’altro interessati a una nuova, possibile valenza da attribuire alla referenza rappresentativa.
In altre parole, viene messo in crisi il quadro come evento irripetibile che si giustifica unicamente sulla base di un codice di interpretazione ritenuto non più sufficiente. Infatti, quando viene analizzato criticamente, il codice della tradizione mostra chiaramente la sua struttura gerarchica, modellata in un contesto che tendeva a considerare invariabili alcuni valori. La struttura rigida di questo manuale è rispecchiata fedelmente nel quadro, dove la prospettiva stabilisce un ordine nella organizzazione dell’immagine e della stessa struttura cromatica. Così, la figura in primo piano non è percepibile più facilmente solo per l’illusione prospettica, ma anche perché la sua preminenza è sottolineata volutamente dalla luce e dalla qualità stessa della pittura. A questo risultato concorrono sia il chiaroscuro, sia la indeterminazione formale via via maggiore delle figure che sfilano secondo l’ordine stabilito a priori.
Cézanne e Seurat contraddicono questo principio, annullando la preminenza di una parte del quadro rispetto al resto, e ponendo invece sullo stesso piano di valore tutti i punti della superficie. Lo sguardo non è più attirato lungo un percorso in cui ogni elemento occupa gerarchicamente la sua posizione, ma è libero di spaziare sulla superficie e di interpretare le possibili relazioni tra tutti gli elementi che compongono il quadro. Ad accentuare questo scarto tanto importante per gli sviluppi che ha favorito, si aggiunge la nuova interpretazione della funzione del colore. In una visione della pittura pensata gerarchicamente, il disegno assume una importanza inevitabilmente preliminare alla pittura stessa. Non a caso i processi spaziali sono quelli che tradizionalmente si configurano con il chiaroscuro, cioè con il grigio, considerato la soglia del processo di cromatizzazione.
Il disegno è così l’ordine sotteso alla fantasia del colore, il colore è l’attributo del disegno. Cézanne rifiuta questa interpretazione. In natura i contorni delle cose non esistono, sono una nostra invenzione mentale, di comodo. L’unica realtà con cui ci è possibile entrare in rapporto con la vista è quella percepibile attraverso il colore: sarà allora il colore a decifrare i rapporti tra le figure e quindi, di conseguenza, le figure stesse. Dunque « a differenza della scultura che occupa lo spazio in quanto forma tangibile, la pittura occupa lo spazio in quanto colore»(11). Se ne può dedurre che è «nella struttura del colore e non nella forma che si devono cercare i significati della pittura»(12).
IL COLORE E LA FORMA
In pittura, ogni principio di spazializzazione si fonda sulla dicotomia fondamentale cromatismo-acromatismo; ogni possibile modo di funzionamento della pittura consiste nell’accostamento-impasto di colori, che non sono però quelli astratti dello spettro solare, ma quelli materiali dati da un pigmento fisico. D’altra parte, solo a questo livello il bianco e il nero appaiono accanto agli altri sette colori dello spettro, ponendosi come limite della comparsa e della scomparsa della luce.
Questa premessa serve a calare il discorso nella concretezza dell’operazione pittorica. Come è già stato osservato(13), non è un caso che Picasso e Braque, nella fase di messa a punto del cubismo, che comporta una forte denominazione spaziale, usino prevalentemente toni di grigio (che con il bianco e il nero compone il triangolo acromatico); mentre nel fauvismo e già nell’impressionismo dove c’è distruzione di uno spazio preciso, si escludono bianco-nero-grigio e si ricorre sistematicamente ai tre colori primati (triangolo cromatico) opposti a quelli complementari.
Questi problemi sono sempre stati al centro dell’indagine pittorica moderna e contemporanea, sia pure spesso quasi inconsciamente. Lo stesso Mondrian, che pure aveva avuto ben chiara fin dall’inizio l’esigenza di una radicale decostruzione formale e spaziale, arrivò negli ultimissimi anni a rimettere in questione le sue idee sulla linea e sul colore, affermando che fino ad allora il suo lavoro in bianco e nero, con piccoli piani di colore, non era stato altro che «disegno dipinto ad olio». Questa consapevolezza, lungi dal diminuire in qualche modo l’importanza dell’opera precedente, lo portò a liberare il colore e a dipingere gli ultimi stupendi quadri (come Brodway boogie-woogie) che sono una indicazione e un invito per tutti i pittori che ne hanno compreso il senso profondo.
Un discorso simile vale per Matisse, che nella tarda maturità recuperò interamente le intuizioni del fauvismo e, con le carte dipinte, giunse a decantare completamente la forma «disegnando con le forbici, tagliando a vivo nel colore». Siamo nel cuore della pittura contemporanea: il colore non è più complemento della forma, ma finalmente protagonista.
E ancora gli esempi potrebbero andare da Van Gogh che disegnava con il colore, a Cézanne che costruiva con il colore; dagli espressionisti tedeschi che forzavano il colore (sia pure con declinazioni letterarie) fino a fargli stravolgere lo schema spaziale preordinato, agli artisti americani dell’action painting che al colore hanno recuperato parte almeno della sua autonomia e della sua virtualità; da Tatlin, per cui la ragione stessa della vita era il puro esperimento al di fuori di qualsiasi schema, a Malevic che proponeva un nuovo alfabeto del colore, con leggi sue proprie, perché diventasse una unità autonoma, nell’ambito di un sistema in cui la teoria fosse complementare all’esperienza.
E’ a queste premesse che si rifà la pittura più consapevole di oggi e questi sono alcuni dei motivi per cui ci si oppone sia alle sclerotizzazioni della Scuola di Parigi, sia a tanta pittura neogeometrica, che poggiano le loro basi ancora sull’illusionismo naturalistico e sulla subordinazione del colore alla forma.
IL COLORE E LO SPAZIO
Come è legato alla forma, il colore non può essere separato dallo spazio. Fino a Cézanne, la prospettiva ha dato la regola della convenzione spaziale. A Cézanne, che contraddice la canonicità di quel presupposto, segue il cubismo che, pur scomponendo la figura, continua a inscriverla in uno spazio tridimensionale, e quindi naturalistico.
E’ questo uno degli equivoci della pittura contemporanea, messo già in luce, in particolare da artisti francesi(14). Senza naturalmente ignorare la grande rilevanza di questo movimento nel processo di decostruzione formale, ci si è accorti infine che moltiplicare i punti di vista della figura non significa annullare l’antico parametro della prospettiva, come non significa rifiutare la referenza rappresentativa. In una certa misura, anzi, sì può dire che il cubismo è stato una involuzione riduttiva dei problemi posti da Cézanne che, la sua immagine, non la mimetizzava come Picasso e Braque, ma se ne serviva come pretesto.
La convenzione prospettica del cubismo condanna ancora la pittura alla dimensione speculare del quadro, alla raffigurazione metaforica della realtà; ecco perché la ricerca di un nuovo spazio passa attraverso la critica di quello cubista, che ri produce le antiche sudditanze, e riparte da Cézanne. Il passaggio dal quadro alla pittura avviene con la frantumazione degli ordini gerarchici che immobilizzano il risultato in una dimensione fittizia, e contemporaneamente con il recupero dell’arte come procedimento di e in trasformazione continua. Solo allora gli elementi della pittura, recuperata la loro autonomia, potranno entrare in aperta dialettica tra di loro e con le forze che li determinano: il soggetto e la storia. Lo spazio non sarà allora né un contenitore da riempire, né un valore che, per una convenzione qualsiasi, presiede al processo della pittura, ma il risultato finale di una complessa integrazione dinamica; e il colore riconquisterà la sua funzione di catalizzatore della visione.
NUOVI ELEMENTI
Quando salta l’ordine gerarchico che privilegiava alcuni elementi della pittura considerati fondamentali (linea, disegno, colore, ecc.), ci si accorge che emergono al loro livello, e con pieno diritto, altre componenti non meno importanti: la superficie, la dimensione, il supporto, i materiali e così via. Si moltiplicano anche i possibili rapporti tra questi elementi, da quello tra la superficie dipinta e il supporto, a quello tra lo spazio e i materiali.
Quando Duchamp conferisce valore ad uno scolabottiglie collocandolo in una galleria d’arte, in realtà non sconfessa l’arte, ma ne verifica i diversi confini, compiendo una operazione di straniamento che alla distanza si è rivelata paradossalmente di tipo classico.
Lo stesso discorso vale per la pittura metafisica, i surrealisti e perfino l’arte di comportamento che, casomai, sconfessa a volte se stessa e le proprie ambizioni riducendosi a esaltazione acritica di trovate e gags avanguardistiche.
Un esempio più recente riguarda la tela svincolata, da Viallat, al suo tradizionale supporto di legno. Ora, sembrerebbe che tutto il valore di questo pittore consista in questa invenzione che lo ha diversificato dai suoi colleghi. Ma una sua dichiarazione, secondo cui tutto è cominciato perché non avendo spazio nel suo atelier era costretto a tenere le tele arrotolate, ha fatto giustizia di tanta approssimazione. Cioè l’operazione non è stata inventata da Viallat: questi ne ha individuato la obiettiva novità avendo la consapevolezza critica che essa rientrava in una nuova teoria della pittura, dove ogni elemento tanto più serve al discorso quanto più conserva la sua autonomia. Ciò non significa naturalmente che si deve seguire questa originale indicazione, ma che questa indicazione è valida e fa parte di un più articolato bagaglio della pittura.
Altri esempi potrebbero riguardare le shaped canvas, dove si tenta di eliminare il fondo tradizionale della pittura facendo coincidere il contorno dipinto con quello fisico del supporto; oppure i formati giganteschi dei pittori americani, dove è evidente il tentativo di uscire dal (riquadro del) quadro ponendo lo spettatore nella pratica impossibilità di abbracciare con lo sguardo i confini della tela da una distanza media.
E ancora i buchi e i tagli di Fontana, le materie di Burri e di Manzoni, le indagini di Dibbets e di Paolini: procedimenti che tengono conto dei mutati termini del fenomeno artistico, ma che acquistano rilevanza solo in quanto elaborano di fatto una nuova teoria dell’arte.
L’equivoco fondamentale della pittura contemporanea è là dove si ritiene che i nuovi elementi e i nuovi materiali abbiano di per sé la capacità di assumere pregnanza conoscitiva. Di fronte alla strada chiusa cui inevitabilmente conducono questi miraggi, ci si difende predicando la morte dell’arte oppure esorcizzando privati fantasmi.
La pittura, invece, è volta a indagare tutte le possibilità che le sono connesse in quanto processo di conoscenza; senza tuttavia dimenticare che questa facoltà è alla sua portata solo se .non si rinnega come disciplina, come procedimento specifico. Recuperare al colore il suo significato, allora, non significherà inaridirsi in una dimensione scientifica o misticheggiante, ma prendere consapevolezza degli strumenti da usare per decifrare il proprio rapporto dialettico con la realtà.
L’ESPERIENZA PERSONALE
II discorso sulla pittura non ammette, per la sua stessa natura, confini precisi, trattandosi di un procedimento che è immerso nella dimensione del movimento e della trasformazione. Questo senza tener conto che «il discorso che incomincia dal dipinto, a partire dal dipinto, è altrettanto libero e significativo del discorso che arriva al dipinto, che in esso si conclude. Si potrebbe dire che in questo senso il dipinto è una pausa: nella sua doppia funzione di chiudere e di aprire – di separare, di mettere contro»(15)
.
In qualche modo, come il dipinto vive di. questo confronto, anche il discorso sulla pittura non può rinunciare alla dialettica di tutti i momenti della sua storia e della sua attualità. Ma l’identificazione di teoria e prassi nella concretezza del lavoro
personale non consente all’artista di cogliere, in modo sistematico, la diversa complessità del problema: questo è il compito dello storico dell’arte.
Al pittore non resta che testimoniare l’aspetto consapevole della sua esperienza.
NOTE
1) M. Picone – R. Riccini, «II ritorno alla pittura» in OP. CIT. n. 33, maggio 1975.
2) Filiberto Menna, catalogo «La riflessione sulla pittura», Acireale, settembre 1973; vedi inoltre, dello stesso autore, «La linea analitica dell’arte moderna», ed. Einaudi.
3) Sol Le Witt, 1967.
4) Giorgio Cortenova, catalogo «Empirica, l’arte tra addizione e sottrazione», Rimini 1975.
5) Marisa Volpi Orlandini, voce «Arte minimal e concettuale» su aggiornamento «Enciclopedia universale dell’arte».
6) Emilio Tadini, catalogo personale Galleria Marconi, Milano, 1974.
7) Vedi Achille Bonito Oliva, «Arte e sistema dell’arte», ed. Galleria De Domizio, Pescara 1975.
8) Marc Devade, intervista a C. Millet su Flash art n. 54-55, Milano, 1975,
9) Marcellin Pleynet, «L’insegnamento della pittura», ed. Mazzotta, 1974.
10) M. Pleynet e i pittori che curano la rivista «Peinture».
11) Dora Vallier, Malevic e il modello linguistico in pittura su «Critique», Paris, marzo 1975.
12) Idem.
13) Idem.
14) Buren, Devade, ecc.
15) Emilio Tadini, idem

