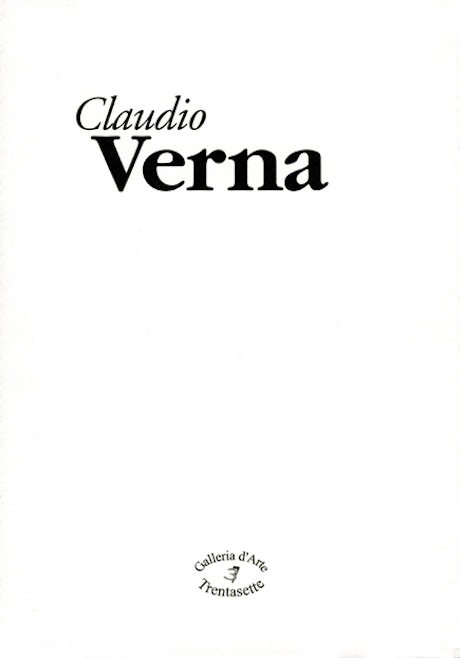 Claudio Verna, catalogo personale Galleria Trentasette, Palermo, ottobre 2006
Claudio Verna, catalogo personale Galleria Trentasette, Palermo, ottobre 2006
Pochi termini hanno generato, nei corso della pittura del Novecento, tanti fraintendimenti ed equivoci come quelli di superficie e profondità: soprattutto a partire dagli anni Quaranta, da quando cioè Clement Greenberg individuò quale carattere cruciale delle opere della cosiddetta Scuola di New York quel valore della bidimensionalità che nello slancio critico e polemico assurgeva a criterio spartiacque tra la precedente tradizione, benché ancora prossima e tutt’altro che esauritasi, e la nuova temperie culturale. Ciò che Greenberg assumeva a bersaglio era ogni residuo dubbio mimetico di cui la nozione stessa della profondità spaziale poteva farsi involontaria portatrice, e con essa l’idea stessa di rappresentazione così come si era codificata nell’arte occidentale, scossa dalle fondamenta ma non ancora sradicata dalla vicenda delle avanguardie. I valori di piano e di superficie dove si svolgeva l’atto della pittura — che non rappresentava quindi nello spazio, ma piuttosto accadeva nel tempo — divennero così, ugualmente, strumento di una esplicitazione riflessiva della pittura stessa: delle sue attitudini come dei suoi specifici mezzi espressivi, dei suoi codici e linguaggi come delle sue interrogazioni, dei suoi dubbi e del suo esitare. E tuttavia, e quasi per paradosso, era proprio quell’indagine della pittura intorno alla propria origine e ai propri compiti — la continua, oscillante tensione tra condizione ancestrale e volontà progettuale — a reintrodurre, e anzi a, rendere centrale, l’idea stessa di profondità; solo, non più proiettata nella organizzazione complessiva dello spazio quanto, semmai, secreta dal tempo in ogni particella di materia di colore, restituita in ritmo e pulsione, ritrovata nei corrugamenti e nelle voragini della stesura pittorica, nei suoi gorghi non meno che nelle sue silenziose e rarefatte emanazioni luminose. Del resto, se il tempo e davvero la struttura mobile che anima senza tregua e agita tanta parte della pittura, moderna, è al tempo che, finanche nel linguaggio comune, noi riconduciamo l’esperienza immediata — l’intuizione — della profondità.
Contrariamente a quanto riteneva Hans Sedlmayr, quando denunciava il depauperamento del valore simbolico della luce come una delle manifestazioni più evidenti di quella perdita del centro che nella sua prospettiva è il peccato di origine della condizione della modernità, è stata proprio la luce, al contrario, a prendere in carico questa rinnovata centralità della profondità del tempo; in Rothko, per fare riferimento ad un artista il cui nome è stato spesso richiamato a proposito di Claudio Verna — ma ugualmente potrebbe dirsi di Barnett Newman o di Ad Reinhardt — per quella conciliazione intima tra le forme (e le ragioni) della geometria e il costante, lento moto di espansione luminosa che si ritrova, in modi differenti, nella prima stagione della maturità dell’artista, tra, gli anni Sessanta e i Settanta: quando cioè, dopo l’esordio avvenuto al finire del decennio precedente, nella stagione in cui la nebulosa dell’informale italiano bruciava le energie residuali rischiando talvolta l’accademia, Verna era tornato a esporre dopo un raccoglimento di alcuni anni, al tempo in cui l’arte povera e la presenza nuda degli oggetti e delle materie sembrava proclamare, senza quasi margine di appello, il superamento definitivo dell’esercizio della pittura riassorbito nella dialettica progressiva delle neoavanguardie. Nessun dubbio tuttavia, neppure in quel clima dove l’intenzione programmatica e progettuale sembrava potere offrire alla pittura un’ultima sponda, sussisteva riguardo a quelle opere, che in alcun modo potevano essere ricondotte per intero al dominio del calcolo e della, ipostasi razionale: già allora, le bande di colore si presentavano come presenze oscillanti, frequenze di luce che nella superficie della tela definivano un moto ipnotico di avanzamenti o di arretramenti, formulando un mobile e aperto sistema di interferenze che aveva, per fulcro, una spazialità fluida che la geometria non bloccava ma, semmai, ipotizzava e ve-rificava come trama elementare della visione. Non a caso i margini che accompagnavano quadrati e rettangoli si presentavano, a tratti, smangiati, ispessiti o rarefatti nella continuità del segno grafico e della materia, e comunque irregolari; e anche quando l’intero piano veniva ripartito dalle sequenze apparentemente uguali e seriali, era l’oscillazione della luce a dissolvere le griglie di verticali e orizzontali giocando con l’ambiguità percettiva di figura, e sfondo non come un teorema, ma come una evocazione del potere della pittura dalle profondità della spazialità di colore.
Come è noto, a quella stagione seguì a partire dalla metà degli anni Settanta un ulteriore momento della ricerca: affidata adesso a una stesura più mossa, alle tonalità più calde del colore ad olio anziché, come in precedenza, a quelle più secche e industriali degli acrilici, e ad una, diversa stesura di stratificazioni, trasparenze e velature; e, ancora, al ductus più acclarato che con una gestualità breve, non impulsiva, coagulava i fluttuanti segni transitori di un alfabeto congetturale simile a un paesaggio di iridescenze, di bagliori, di ombre e di riflessi intrecciati nella trama della, medesima, sostanza. Ma anche in questo ampio ciclo temporale e di opere che ha attraversato pressoché per intero gli anni Ottanta e Novanta come un ininterrotto ricercare musicale, il dissolversi della filigrana geometrica negli impasti e nelle tonalità non ha portato con sé un fraintendimento di abbandono lirico; al contrario, ogni sedimento di pittura sulla tela — il ritmo impresso al colore, il suo sovrapponi o sfumare nella campitura contigua, il sommarsi e quindi il fondersi dei toni in un precipitato abbacinante o il loro addensarsi in una oscurità di abisso primigenio — metteva in opera un mosaico in cui nessuna tessera era casuale, e ognuna necessaria come nella struttura matematica di una costruzione armonica o nella fascinatoria, vertiginosa bellezza della geografia dei frattali (esempi, entrambi, che presuppongono e inglobano il tempo).
Se, nelle opere degli ultimi anni, Verna è tornato a utilizzare gli acrilici e, contemporaneamente, a organizzare talvolta la superficie del dipinto con una rinnovata presenza di geometrie (fasce laterali di colore verde o viola, come in Est e Ovest, regolari sequenze di brevi linee disposte a croce, come in Infuocato, sottili bande gialle che traversano l’intero campo lievemente sghembe e sfalsate, come in Esprit de fìnesse), questo non ha comportato un moto di conversione, quanto, semmai, un ulteriore momento di verifica e di esplorazione. Allentata la capacità seduttiva dell’olio, ma non il gioco di sovrapposizioni, incastri, richiami e assonanze che ne caratterizzava la stesura, questa pittura ha dunque proseguito nel suo interrogarsi sulle questioni dello spazio e del colore, della luce e del tempo: un percorso ciclico, ritornante come è quasi sempre quello dei grandi pittori, e dove, forse mai in modo così evidente nella produzione di Verna, il motivo del confine e del limite e enunciato come un problema insieme figurativo e mentale, fisico e filosofico. Anzi, come il problema: così, ad esempio in Contrappunto o in La fiamma, le vaganti condensazioni di blu su campo arancio e rosse su campo verde (colorì complementari, va detto; ma ai margini di contatto si addensano e subito scompaiono striature maculate di celeste, di viola) si dispongono come costellazioni e nebulose, suggerendo — lo aveva già rilevato Anassimandro a proposito della volta stellata — che queste fiamme esili, questi fuochi fatui e miraggi di colore siano il riflesso altrimenti insostenibile di una entità assoluta che filtra al di là del piano; e, in Infuocato, la griglia di piccole croci evanescenti allude a una infinitezza che l’arancio della tela subito sprofonda, e fagocita nel gorgo muto. Perché lo sguardo che si sporge su sé stesso e sul proprio orizzonte si imbatte, sempre, nella vertigine del silenzio e del vuoto.

